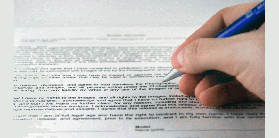|
IL BLOG DI ADR - CEL: argomento |
Torna all'indice degli argomenti
TIPI DI MEDIAZIONE E REQUISITI DEI MEDIATORI
Dott. Eduardo SORRENTINO
Lo strumento della conciliazione giudiziale, nei sui termini essenziali, è conosciuta ed utilizzata fin dai tempi dell’antica Roma, e da lì, anche attraverso l’influenza dell’ordinamento ecclesiastico, introdotto nel primo codice di procedura civile dell’Italia unita avvenuto nel 1886. “rem ubipacunt, orato. ni pacunt, in comitio aut in foro ante meridiem caussam coiciunto.” Le parti in lite che raggiungano un accordo hanno il diritto di ricevere dal giudice l’emanazione della sentenza che racchiuda il loro volere. questo e’un frammento delle XII tavole del diritto romano La figura del giudice conciliatore, come è noto, è stata poi sostituita, in tempi più recenti, da quella del giudice di pace, caratterizzata da una preponderanza della funzione giudicante rispetto a quella finalizzata all’amichevole composizione della lite. Sulla spinta delle esperienze maturate in altri paesi ed in particolare negli Stati Uniti d’America, si è cominciato a diffondere, anche in Italia, la metodologia propria dell’a.d.r. (alternative dispute resolution) che prescinde dall’intervento diretto o indiretto dell’autorità giurisdizionale. È infatti negli usa che si sono affermate le prime forme di giustizia privata, alternativa a quella ordinaria, sulla base di un articolato movimento culturale che ha portato alla nascita dei sistemi di risoluzione delle controversie più conosciuti con l’acronimo di A.D.R. Generalmente in Italia per consuetudine e fino all’entrata in vigore del D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, con il termine “mediazione” si intendeva quel sistema informale di gestione e composizione dei conflitti ad opera di terzi imparziali che assistono le parti in materia familiare, sociale, scolastica e fin’anche penale. Con il termine “conciliazione” invece, si alludeva ai procedimenti di risoluzione delle controversie nell’ambito delle materie civili, commerciali e di lavoro, con un’ulteriore sottodistinzione fra conciliazione giudiziale (cioè il tentativo esperito dal giudice) e conciliazione extragiudiziale (il tentativo esperito da un soggetto esterno all’ordinamento giudiziario ) . Opportunamente si è ritenuto di superare la distinzione tra i due termini sottolineando come la mediazione rappresentasse la tecnica di avvicinamento tra posizioni contrastanti tese ad integrarsi nella conciliazione, intesa come risultato. Il D.lgs. 28/2010 pone fine alla problematica, operando una netta distinzione tra mediazione intesa come il procedimento volto alla risoluzione di una lite e la conciliazione che è il risultato di detto procedimento. Concetto riaffermato dal legislatore nell’art. 1 lettere c) d) ed e) ove per mediazione si intende “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa Per conciliazione “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione ”- e per mediatore “la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo” Con la riforma del processo civile il tentativo di conciliazione, introdotto dal D.lgs. 28/2010, è obbligatorio in tutte le controversie in materia di diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale da eccepirsi dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza. A seguito dell’approvazione del c.d. decreto “mille proroghe” n. 225 del 29 dicembre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010 è slittato di un anno (marzo 2012) l’entrata in vigore dell’obbligatorietà per due materie e precisamente: il condominio ed il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Indubbio è l’obiettivo del legislatore nel porre in essere la mediazione quale strumento obbligatorio nel procedimento civile. Lo scopo, infatti, è quello di ridurre il flusso di ingresso di nuove cause nel sistema giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi. La mediazione può essere: • facoltativa: cioè scelta dalle parti • obbligatoria: quando per poter procedere davanti al giudice le parti debbono aver tentato, senza successo la mediazione • demandata: quando il giudice, a cui le parti si siano rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione non avendola esperita in precedenza. Le procedure di alternative dispute resolution sono spesso indicate con diverse terminologie tendendo a sottolineare un particolare aspetto anziché un altro. Potremmo definirle tecniche di giustizia informale, attesa l’assenza di schemi rigidi precostituiti e di semplicità nelle procedure, oppure procedimenti sommari, attesa la velocità di esecuzione, o ancora che agevolano l’accesso alla giustizia preso atto della ridotta onerosità. Le principali forme di ADR più importanti, sono: l’arbitrato; the early neutral evaluation, the mini trial, the mediation, the fact-finding, the mediation-arbitration, the summary jury trial, the dispute review board, the partnering. Orbene nella mediazione fondamentale è il ruolo del mediatore. Trovare quindi organismi di conciliazione accreditati dal Ministero di Grazia e Giustizia, che annoverino tra i propri mediatori professionisti capaci, di fornire alle parti in lite, nella fase di negoziazione, una struttura dinamica e flessibile consentendo alle stesse il superamento delle impasse nella loro contesa è elemento indispensabile per la risoluzione della lite. Per questi motivi si è ritenuto opportuno, anche se succintamente, evidenziare il ruolo del mediatore enfatizzando le capacità di negoziazione e l’importanza che questi riveste nella conciliazione, partendo da come diventare mediatore e da come comportarsi nel corso della conciliazione. La figura del mediatore è di natura metagiuridica ed ha il ruolo, principale, di assistere alla negoziazione delle parti. Il mediatore viene definito dal legislatore come la persona o le persone fisiche che individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, di potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. In sostanza gli elementi che caratterizzano l’attività del mediatore possono essere i seguenti: • lo scopo; • i limiti; • le diverse attività. Lo scopo del mediatore è quello di dare alle parti in lite aiuto a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe. Quando si parla di aiuto si intende un’assistenza neutrale che non vada ad influenzare le decisioni delle parti, non ponendo in essere alcuna pressione su di esse né tentare un’azione di convincimento di una propria soluzione. Con il termine accordo s’intende il raggiungimento di una soluzione alla lite. l’accordo non è indispensabile alla conciliazione. Infatti il mediatore deve considerare l’accordo come un frutto importante ma, il non raggiungimento dell’accordo non può e non deve significare un fallimento della conciliazione, perché il solo fatto di avere dato la possibilità alle parti di esprimere le loro opinioni è già un traguardo. I limiti sono dati dalla natura stessa della conciliazione e quindi dal fatto che sopra ogni cosa primeggia la volontà delle parti, elemento questo che contraddistingue la conciliazione differenziandola dal giudizio ordinario e dall’arbitrato. Altri limiti si desumono dalle norme di comportamento cui i mediatori sono assoggettati dagli enti che amministrano le procedure di conciliazione (regolamenti e codice etico) In sintesi l’unico vero potere del mediatore è quello di avere la facoltà di rifiutare l’incarico e di abbandonare l’incarico ricevuto se la conciliazione imbocca percorsi da egli non condivisi. I doveri del mediatore sono innanzitutto la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità nei confronti dei litiganti. La figura del mediatore si caratterizza per l’essere il depositario delle confidenze delle parti in corso di trattativa con l’obbligo di mantenerne il riservo (riservatezza). È tenuto inoltre a rispettare le norme istituzionali dell’organismo presso cui opera. Non è un pubblico ufficiale e quindi non ha specifici doveri o obblighi di denuncia in relazione al proprio ruolo. Gli obblighi del mediatore sono elencati nel D.lgs. 28/2010 agli artt. 9 e 14. L’attività del mediatore può essere suddivisa in quattro macro aree: conflitto; comunicazione; negoziazione; problema tecnico. L’attività del mediatore è fondamentale poiché ha il delicato compito di scavare, con empatia e delicata accortezza, nel profondo delle parti in lite individuando gli interessi sommersi , veri elementi trainanti per la risoluzione della lite, sui quali individuare soluzioni realistiche che guardino al futuro salvaguardando i bisogni delle parti. Il mediatore ha il compito di allargare gli orizzonti a possibili soluzioni negoziali che consentano ad entrambe le parti di ottenere un risultato soddisfacente, abbandonando quindi il confronto muro contro muro poiché non si avranno sul campo né vinti né vincitori. Risultato questo, improponibile ed irrealizzabile in giudizio ed in arbitrato ove il giudice o l’arbitro si attribuisce il potere di decidere il torto e la ragione ad un terzo. Con la sentenza, nell’esercizio delle sue funzioni, il giudice o arbitro stabilirà un vincitore ed un vinto, perdendo la disponibilità della controversia e del suo esito. In conciliazione, invece, le parti mantengono fino alla fine la disponibilità dell’esito finale della controversia. I litiganti, contrariamente a quanto in giudizio ed arbitrato, hanno la possibilità, in qualsiasi momento della conciliazione, di alzarsi dal tavolo delle trattative ed abbandonare la negoziazione. In conciliazione il mediatore fornisce una struttura dinamica e flessibile alle parti in lite consentendo alle stesse il superamento delle impasse nella loro contesa. Durante tale negoziazione si da spazio ad elementi soggettivi quali l’emotività, con l’obiettivo di fare emergere aspetti di natura comunicativa e relazionale per poterli far prendere in considerazione alla controparte. Come si diventa mediatore il D.lgs. n. 28/2010 ha per la prima volta delineato anche un quadro normativo generale su taluni obblighi del mediatore. Le novità introdotte, molto numerose, rappresentano un cambiamento assoluto rispetto alla tradizione della conciliazione nel nostro Paese. Un cambiamento complessivamente positivo nel quale è, senz’ombra di dubbio, opportuno e doveroso evidenziare il cambio di marcia impresso dal legislatore in questo specifico ambito. Le basi sulle quali il D.lgs. 28/2010 trova fondamento traggono origine in due precedenti atti normativi di rilievo e precisamente il D.lgs. n. 5/2003, in materia di conciliazione relativa le controversie societarie, e la direttiva 2008/52/ce in materia di mediazione delle controversie transfontaliere. Il primo ha contribuito a diffondere la cultura e la conoscenza della conciliazione, dettando alcuni aspetti normativi che rappresentano elementi fondamentali dell’istituto quali ad esempio la riservatezza. La seconda ha introdotto nuovi principi per il nostro Paese, che il legislatore ha recepito e fatti propri legiferando in materia. Altro pilastro del D.lgs. 28/2010 è senza dubbio la legge 69/2009 e precisamente l’art. 60 che contiene la delega con la quale il parlamento ha stabilito i principi cardine a cui il governo si è successivamente attenuto. Nessuna categoria professionale può rivendicare l’esclusiva competenza nella conciliazione. Il legislatore contrariamente a quanto disposto nel dm 222 del 23 luglio 2004 art. 4 comma 4°lettera a) ove venivano fissati i requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori, per i quali ove non fossero professori universitari in discipline economiche o giuridiche, o professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni, ovvero magistrati in quiescenza, dovevano risultare dal provato possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati presso il responsabile in base ai criteri fissati a norma dell'articolo 10, comma 5, ha stabilito, con il D.M. 180/2010 art. 4 comma 3° lettera a, che possono essere mediatori tutti i soggetti che possiedono un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale ed alla lettera b dello stesso articolo, decreta che il mediatore deve essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione di cui all’art. 18 del D.M. 180/2010. Tale norma rafforza il principio innanzi enunciato e cioè che il mediatore è una figura professionale capace di risolvere la lite in corso tra le parti riuscendo a conciliare i bisogni delle stesse previa emersione degli interessi sommersi. Il legislatore, ha torto o ragione, sostiene quindi, che per tale attività non è indispensabile l’esclusività del dottorato in materie giuridiche-economiche, ma esperienza professionale in campo di mediazione acquisita tramite continua formazione oltre che ad un impiego concreto e costante nella conciliazione. Recentemente il legislatore con il D.M. 145 del 6 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. 197 del 25 agosto 2011 ha apportato ulteriori sostanziali modifiche al prefato D.M. 180/2010. Nel confermare l’importanza dell’obbligatorietà della mediazione civile nella struttura della giustizia italiana il legislatore ha manifestato e rafforzato la volontà di proseguire nel cammino dell’A.D.R. quale strumento per la risoluzione delle controversie, ritenendo a sommesso parere, la mediazione obbligatoria una strada di non ritorno!! Le sostanziali novità introdotte dal D.M. 145/2011 sono: • prevedere un tirocinio assistito per i mediatori • i criteri per l’assegnazione degli affari di mediazione • la correzione delle indennità in caso di mediazione obbligatoria e mancata partecipazione. ai mediatori viene richiesto oltre al possesso di una specifica formazione ed aggiornamento almeno biennale (così come disposto dall’art. 4 comma 3 lett. b del D.M. 180/2010), ai sensi dell’art. 2 del D.M. 145/2011 anche la partecipazione nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi di mediazione iscritti negli appositi albi ministeriali. Il legislatore ha infatti ribadito all’art. 8 comma 4 del D.M. 145/2011 che l’organismo di mediazione è obbligato a consentire al mediatore il tirocinio assistito, in via gratuita e disciplinandolo nel proprio regolamento. È d’uopo che gli organismi già accreditati abbiano dovuto modificare con solerzia, come per altro fatto da A.D.R. - C.E.L. , il proprio regolamento inoltrandolo con le dovute modifiche al Ministero della Giustizia. Il legislatore ha anche voluto chiarire i criteri di assegnazione del mediatore da parte dell’organismo che dovrà tenere conto della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta. Per quanto attiene la disciplina transitoria viene estesa a 12 mesi, dalla data di entrata in vigore del D.M. 145/2011, il periodo che consente ai mediatori abilitati presso gli organismi e quindi già iscritti nel registro di cui al D.M. 222/2004, di acquisire i requisiti formativi previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di avere svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale (art. 20 dm 180/2010 modificato dall’art. 6 D.M. 145/2011) Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei dodici mesi di cui al periodo precedente, possono continuare ad esercitare l’attività di mediazione. Sarà cura degli organismi dare comunicazione al Ministero della Giustizia dell’avvenuta acquisizione dei requisiti. Si può affermare quindi, e senza ombra di smentita, che la conciliazione favorisce il dialogo e la comunicazione; aiuta la negoziazione condotta dalle parti mutandone le dinamiche; sfrutta le tecniche di negoziazione per facilitare il raggiungimento dell’accordo; sposta l’attenzione delle parti dalle posizioni basate sui fatti del passato ai bisogni ed agli interessi del presente e del futuro; favorisce un’analisi di realismo sul proprio caso e sulle soluzioni prospettate; allarga le possibili soluzioni aumentando le scelte e le opzioni di risoluzione dando spazio alle emozioni; consente di superare blocchi emotivi. Infine e non ultimo, aiuta a ricostruire i rapporti tra le parti in lite. In sintesi, nel ringraziarvi per l’attenzione prestata, si può concludere affermando il concetto che nella mediazione il bisogno prevale sul diritto! Grazie.
- Postato il: 05/12/2011, alle ore: 11:26:13